Renato Tamburrini
Note sul dialetto di Settefrati

2a edizione
Copyright Renato Tamburrini, settembre 2008
Questo documento è concesso dall’autore per la pubblicazione sul
sito
www.settefrati.net. I diritti d’autore non sono ceduti. La
citazione, la riproduzione integrale o parziale e la diffusione
per scopi non commerciali sono autorizzate, purché sia indicata
sempre la fonte. Non è permessa la modifica del testo e il
suo utilizzo per fini di lucro. .
Carta
dei dialetti italiani

-
Premessa
top
1.1 Lingua e dialetto
top
Anche se oggi
quasi tutti quelli che parlano in dialetto lo utilizzano più o meno
largamente accanto alla lingua “ufficiale” e sono generalmente
consapevoli che si tratta di uno strumento di livello assai diverso
(ovviamente quando sono tecnicamente in condizioni di diglossia,
cioè riescono ad esprimersi in lingua nazionale e in dialetto), non
è altrettanto facile definire bene tutte le differenze. Infatti
anche nella lingua “ufficiale” esistono livelli diversi a seconda
dell’ambiente culturale e sociale e delle finalità della
comunicazione (i cosiddetti registri linguistici). Lo stesso
parlante si può esprimere in modi diversi a seconda del contesto,
dal più familiare al più ufficiale.
In sintesi, per
semplificare al massimo, possiamo dire che una parlata dialettale è
caratterizzata dal non avere una lingua scritta adatta alla
complesssità delle situazioni, dall’essere usata in un territorio
abbastanza limitato e dall’essere inadatta a situazioni di tipo
istituzionale o ufficiale (atti pubblici, scuola, comunicazione
scientifica ecc.).
Proprio per
queste sue caratteristiche il dialetto si va a collocare nel cuore
della “familiarità”, e rappresenta uno degli elementi principali
con cui una comunità si riconosce: le tradizioni, le feste, il
ricordo di un ambiente naturale e antropico comune sono veicolati da
un linguaggio di nicchia, spesso ricco di espressioni idiomatiche e
termini specifici, considerati in questo contesto più pertinenti di
quelli conosciuti attraverso la lingua colta ufficiale.
I dialetti, non
diversamente dalle lingue - anzi in misura maggiore perché non hanno
un corredo di testi scritti paragonabili a quelli che
contribuiscono a rendere più stabili le lingue- non sono immobili
nel tempo e sono sottoposti a cambiamenti anche importanti, per il
continuo interscambio sia con la lingua colta comune che con le
parlate più vicine; anche se i parlanti nell’arco della loro
esistenza non avvertono pienamente l’entità dei cambiamenti e anzi a
volte, quando il corso della storia è più lento, hanno
l’impressione quasi dell’immobilità.
Nel contesto
della civiltà attuale, con l’abbondanza di influenze provenienti dai
media, che si sono aggiunte a quelle classiche della scuola, della
burocrazia statale e della predicazione, è naturale che il dialetto
sia sottoposto a rischi di sopravvivenza e di omologazione in modo
anche brusco.
Proprio con
l’intento di contribuire a fissare un patrimonio sottoposto ad una
veloce dissipazione ho messo un po’ in ordine appunti e riflessioni
che occasionalmente avevo fatto. Lo spirito con cui li ho raccolti e
rielaborati non è certo quello di alimentare rivendicazioni
localistiche o romantiche ricerche di colori primitivi, ma piuttosto
quello di offrire una testimonianza e di arricchire quella
biblioteca ideale di storia patria la cui creazione è uno degli
obiettivi che più volentieri abbiamo vagheggiato con l’amico
Antonio. E mi pare veramente significativo, anche se apparentemente
contraddittorio, che lo spazio per questa testimonianza di identità
sia offerto dalla rete globale del web.
1.2 Obiettivi e metodo
top
Lo scopo di
questo lavoro è quello di offrire una panoramica del dialetto di
Settefrati attraverso la sintesi dei principali aspetti fonetici e
morfologici e la raccolta di parole con l’indicazione del
significato in lingua italiana comune e, quando possibile e
abbastanza sicuro, anche dell’etimologia, soprattutto per quei
termini che apparentemente o sostanzialmente divergono dall’italiano
comune.
Il primo
problema che si trova di fronte a chi voglia affrontare un
argomento di questo genere è la trascrizione: trattandosi di parlate
senza tradizione scritta e con abbondante presenza di suoni non
abituali nella lingua nazionale comune, si può cadere nella più
assoluta arbitrarietà; chi si occupa di dialettologia in modo
professionale ricorre a una trascrizione fonetica che utilizza un
segno diverso per ciascun suono: il risultato è ineccepibile sotto
il profilo scientifico, ma il tutto risulta poi difficilmente
leggibile per il pubblico, anche di media cultura, che si avventuri
con curiosità nella foresta delle parole patrie.
Ritenendo che il
lavoro, che ho cercato di mantenere comunque a un livello seriamente
documentato, non sia tanto destinato agli studiosi della materia,
quanto piuttosto a persone che vogliono approfondire qualche aspetto
del dialetto, prima di tutto ho deliberatamente evitato l’uso delle
note a piè di pagina (salvo due inevitabili ma brevi precisazioni
per quanto riguarda la fonetica delle vocali) che in molti casi
avrebbero sì aiutato ad approfondire qualche punto, ma anche
contribuito ad appesantire ancora di più una materia già di suo un
po’ ostica. Questa scelta è stata anche confortata dall’idea che la
pubblicazione, almeno in questa stesura, è destinata a un sito web
generalmente non frequentato da addetti ai lavori.
Per quanto
riguarda la trascrizione delle parole quindi mi sono tenuto
il più possibile vicino all’italiano comune e perciò ho usato
praticamente solo due accorgimenti: come si può vedere meglio nella
parte dedicata alla fonetica delle vocali, nel dialetto di
Settefrati (ma anche dei paesi vicini) c’è una grande quantità di
e semivocaliche –con un suono contraddistinto da una
forte lenizione ignoto all’italiano comune, ma frequente ad esempio
nel francese- che spesso quando si scrive qualcosa in dialetto non
sono neppure segnalate, perché sono percepite quasi come non
esistenti. Da una parte sarebbe fuorviante trascriverle come la e
dell’italiano comune, che ha sempre un suono pieno, anche quando non
è accentata; dall’altra l’assenza totale della trascrizione sarebbe
ancora più dannosa per la comprensione e ancora più sbagliata dal
punto di vista linguistico; e perciò ho scelto di segnalarle
trascrivendo la “e” come ë (al computer il carattere ASCII si
ottiene con ALT+137), seguendo l’uso prevalente nelle pubblicazioni
di tipo dialettologico; ad esempio, decisamente non va bene
“frrar”, che lo rende incomprensibile e ostico, al pari di f’rrar’,
ma neppure “ferrare”, che solo chi conosce il dialetto potrebbe
pronunciare correttamente: nell’opuscolo e soprattutto nella parte
dedicata al dizionario, si troverà “fërràrë” che garantisce
l’integrità della parola ma avverte che quelle “e” sono deboli o
debolissime. Il secondo accorgimento che ho utilizzato è quello di
segnare comunque l’accento delle sillabe toniche, per la decisiva
centralità che hanno nel sistema fonetico dei dialetti italiani
centro-meridionali, e quindi anche nel settefratese. Con queste due
“regole” spero di essere riuscito a mantenere una certa aderenza
alla reale fonetica del settefratese senza stravolgimenti, e nello
stesso tempo a fornire uno strumento di non troppo difficile
leggibilità.
Non mi sfugge
che anche questi due accorgimenti, specialmente il primo
(segnalazione della e semivocalica) potrebbero però essere
fastidiosi e inadatti allo scopo per tutti coloro che vogliono
scrivere in dialetto (poesie, ricordi, citazione di una parola nel
contesto di uno scritto in lingua…).
Per questa
ragione più oltre (a pag. 13) ho avanzato una proposta complessiva
sulla scrittura del settefratese che potrebbe semplificare il lavoro
e nello stesso tempo presentare le parole dialettali in maniera
leggibile.
1.3 Il quadro
storico: le origini, la koinè romana, la frantumazione
top
Le radici della
storia comune dei popoli che abitano la penisola italiana affondano
sicuramente nei millenni. Ma per quanto riguarda la lingua bisogna
partire dal primo millennio avanti Cristo, anche se relitti di
lingue precedenti (pre-indoeuropee) sono presenti come fenomeni di
sostrato anche nei nostri dialetti.
Nel primo
millennio a.C., con varie ondate, popolazioni di origine e lingua
indoeuropea provenienti dal Nord o, secondo alcuni, dalla penisola
balcanica, entrarono in Italia. Con il nome Osco-Sabelli sono
chiamati tutti i popoli di lingua osca che popolarono la penisola,
esclusa la Padania: non sono compresi gli Etruschi, sulla cui
origine, nonostante tutti gli studi non è stata data ancora una
lettura definitiva, e i Latini, appartenenti anch’essi al ceppo
indoeuropeo, ma arrivati in Italia probabilmente qualche secolo
prima degli Osco-Sabelli. Latini e Osco-Sabelli presentano comunque
molte affinità religiose, culturali e linguistiche. Se ne deduce che
fossero in qualche modo “imparentati”: d’altronde le fonti antiche,
avvolte nella leggenda ma non per questo sicuramente infondate,
legano i Sabini veri e propri sia alla proto-storia dei Romani che a
quella dei Sanniti, una delle etnie più rappresentative del gruppo
osco-sabellico. Attraverso l’interazione con i popoli che già la
abitavano, che gli studiosi generalmente chiamano “mediterranei”
senza pronunciarsi molto sulla loro natura etnico-linguistica, si
formò una civiltà omogenea anche dal punto di vista linguistico:
alcune caratteristiche proprie della lingua osca hanno attraversato
l’unificazione del latino portata dal dominio di Roma, e sono
tuttora persistenti. E’ a questa civiltà italica osco-sabellica (che
nell’insieme si estendeva dalle Marche alla Calabria -dai Piceni ai
Bruzi- e che si espandeva attraverso la pratica delle primavere
sacre) che appartengono i nostri primi antenati documentati dalla
storia. La nostra area era abitata sicuramente da popolazioni di
questo ceppo: quando i Sanniti fecero la loro comparsa nella storia
di Roma (intorno al 350 a.C.) la loro lega, con le grandi tribù dei
Caracini, Caudini, Pentri e Irpini, rappresentava il più forte
raggruppamento italico, e il loro dominio, che si era affermato
nelle zone volsche e premeva verso le città greche della Campania,
comprendeva con sicurezza Atina e Casinum. La valle
del Liri era diventata una zona fortemente critica, in cui
l’espansione romana e quella sannitica vennero in conflitto. A
prescindere dalla veridicità della localizzazione della sannitica
Cominium distrutta dai Romani nel 293 a.C. – comunemente e
secolarmente riferita alla nostra valle, ma messa in dubbio da studi
recenti- in ogni caso è incontrovertibile l’antichità
dell’assetto urbano di Atina e della consistenza del suo territorio
(l’atinate agro di Livio), con la leggendaria fondazione di
Saturno e la fama consolidata di punto nodale della resistenza
italica contro Enea, che le attribuisce Virgilio nell’Eneide. Come
pure incontrovertibile è la presenza del santuario di Mefitis
alle sorgenti del Melfa, vero e proprio locus sacer della
nostra etnia, naturale via di comunicazione tra il Sannio e la valle
del Liri, con un interesse sicuramente incrementato dalla presenza
delle miniere di ferro.
Il mondo
osco-sabellico venne a contatto con la forza dell’espansione romana
che alla fine, dopo quasi tre secoli di lotte sostenute
prevalentemente dal suo nocciolo duro sannita, dovette soccombere:
l’ultimo grande episodio nel I secolo a.C. fu la guerra sociale che
gli alleati italici - che avevano posto la capitale a Corfinium
e battevano moneta con la scritta “Italia”- sostennero contro Roma
per rivendicare parità di diritti: da lì in avanti la nostra area si
innestò fortemente nella possente architettura statuale, militare e
organizzativa del mondo romano (Atina diventa prefettura romana),
fornendo attivamente militari, amministratori, letterati, poeti.
La dominazione
romana, che qualcuno ha definito la prima grande globalizzazione,
comportò una vigorosa unificazione politico-amministrativa e
linguistica della penisola italiana, con una fisionomia
riconoscibile ancora oggi perfino nella divisione regionale, dovuta
soprattutto all’opera di Augusto (30 a.C. -14 d.C), che sotto molti
punti di vista possiamo considerare il vero padre fondatore
dell’Italia. Sostanzialmente questa è la base fonetica, lessicale e
grammaticale di tutti i nostri dialetti, al pari di tutta l’enorme
area linguistica neo-latina. Naturalmente anche il latino parlato
non era omogeneo e regolare come quello che leggiamo nei testi dei
classici, ed è accertata la presenza di varietà locali e livelli
linguistici diversi.
Dopo la caduta
dell’impero romano (476 d.C) la nostra zona fu profondamente
influenzata dai grandi centri monastici benedettini di San Vincenzo
al Volturno e di Montecassino (fondato nel 529 d.C), non soltanto
dal punto di vista religioso e culturale, ma anche
politico-terrioriale. L’afferenza al ducato longobardo di Benevento
e alle sue successive frantumazioni feudali - a partire dalla grande
signoria di Capua- e l’appartenenza al Regno unificato dal normanno
Ruggero II (1095-1154) documentano anche dal punto di vista
amministrativo e politico un radicamento plurisecolare nel Meridione
italiano. L’appartenenza all’area della grande civiltà della
Longobardia minor beneventano-cassinese forse ha lasciato anche
una testimonianza preziosa nel cuore della nostra tradizione, in
quei vespri del 14 e del 29 agosto che, trasmessi oralmente nei
secoli, sono quasi miracolosamente sopravvissuti ai reiterati
tentativi di eliminazione messi in atto anche in tempi recenti. Quei
salmi, quelle antifone, quegli inni, con molta probabilità
riecheggiano i modi del cosiddetto canto lombardo , praticato
nella cattedrale beneventana fino a oltre il 1000 e comunque
sopravvissuto a lungo nel cenobio cassinese. E’ come se una gemma di
un leggendario tesoro del passato fosse stata incastonata nel rito
che forse più di ogni altro esprime l’identità e la memoria
collettiva del paese.
Sul piano
strettamente linguistico, dopo la caduta del dominio poltico
unitario di Roma, in tutto il vasto territorio del suo impero le
differenze si accentuarono, la fonetica si modificò sempre di più, e
accaddero diversi fenomeni di semplificazione grammaticale e
sintattica: si andarono così a formare svariate parlate, all’interno
dell’’insieme delle lingue chiamate romanze o neo-latine.
L’isolamento e la specificità fecero il resto, portando ad una forte
frantumazione dialettale in tutta la penisola italiana, con
particolare virulenza nelle zone montane, più isolate. Nel corso dei
secoli anche i nostri dialetti si arricchirono di parole delle
lingue di altre popolazioni che frequentavano l’Italia, e cosi
abbiamo lemmi di origine gotica o longobarda, e poi francese e
spagnola. In senso opposto, unificante o almeno omologante, agivano
la lingua degli atti governativi e burocratici, la Chiesa con la
predicazione, gli scambi con i paesi viciniori che evidentemente non
cessarono mai del tutto, anche con la l’aumentata difficoltà nelle
comunicazioni.
Dopo l’unità
d’Italia una serie di fenomeni concomitanti andò man mano ad
aggiungersi e a rafforzare la tendenza omologante: basti citare il
servizio militare obbligatorio, gli scambi dell’emigrazione,
l’estensione della scolarizzazione; negli anni Trenta e Quaranta ci
furono l’apparizione della radio, il calcio e le canzoni,
l’organizzazione dei bambini e dei giovani nelle associazioni del
regime fascista; e infine nell’ultimo dopoguerra la televisione, la
scolarizzazione sempre più spinta e in qualche misura anche
l’introduzione dell’italiano nella liturgia.
Nel frattempo la
creazione della Provincia di Frosinone nel 1927, con la separazione
amministrativa dell’area di Sora e Cassino dal millenario retroterra
campano, ha ovviamente comportato un aumento dell’influenza
ciociaro- laziale nei nostri dialetti.
L’azione
costante delle forze di frantumazione e di unificazione ha avuto
come risultato quel dialetto -costantemente parlato per tutto il
secolo scorso e ancora oggi fortemente vitale anche nelle comunità
di emigrati- che molti di noi ancora conoscono abbastanza.
Ovviamente i
parlanti più anziani, o che hanno conservato all’estero il ricordo
di una situazione più arcaica, hanno la percezione nostalgica di uno
strato diverso del dialetto, rispetto al quale quello parlato in
paese, sottoposto ad influenze ed evoluzioni, rappresenta comunque
un allontanamento.
1.4 Il
quadro linguistico
top
Il dialetto
settefratese appartiene alla famiglia dei dialetti
centro-meridionali, che si estendono dalle Marche alla Calabria.
Più precisamente è un dialetto nord-campano con evidenti influenze
delle vicine parlate del Lazio meridionale, dell’Abruzzo e del
Molise.
Il confine di
questa vastissima area linguistica - che corrisponde quasi
perfettamente alle zone di insediamento delle popolazioni
osco-sabelliche prima del dominio romano- è segnato a nord da una
linea che va grosso modo da Roma ad Ancona, mentre a sud ne sono
escluse la Calabria meridionale e il Salento.
La cartina a
pag. 4 mostra un quadro sintetico della ripartizione dei dialetti
italiani.
Lungo la
cosiddetta linea Roma - Ancona ( linguisticamente fondamentale come
quella La Spezia - Rimini, che separa i dialetti nord-italiani da
quelli centrali) corre ad esempio il limite settentrionale
dell’utilizzazione di ferraro per “fabbro”, frate
per “fratello”, femmina per “donna”, figliomo e
similari (patremo, fratemo, ecc.) per “mio figlio”
ecc., tenere per “avere”.
Il fascio delle
isoglosse significative che segnano a nord il confine dell’area
dialettale meridionale è rappresentato dalla carta a pag. 12 (isogl.
8-12); nella stessa carta sono visibili le isoglosse che segnano il
confine tra i dialetti del nord Italia e quelli dell’Italia mediana
(isogl. 1-7).
E’ da
sottolineare come queste linee corrispondano in una certa misura
anche ai confini storici degli antichi stati italiani, cosicché la
Toscana, che già ricalca in buona parte l’area etrusca
dell’antichità, risulta linguisticamente ritagliata tra le due
linee La Spezia-Rimini e Roma - Ancona; mentre quest’ultima,
risalendo dal Lazio verso l’Umbria (sfiorando a sud Perugia) e le
Marche, risale il cosiddetto “corridoio pontificio”.
Della grande
famiglia dei dialetti dell’ area centro-meridionale il settefratese
condivide le caratteristiche fondamentali dal punto di vista
fonetico, morfologico e sintattico.
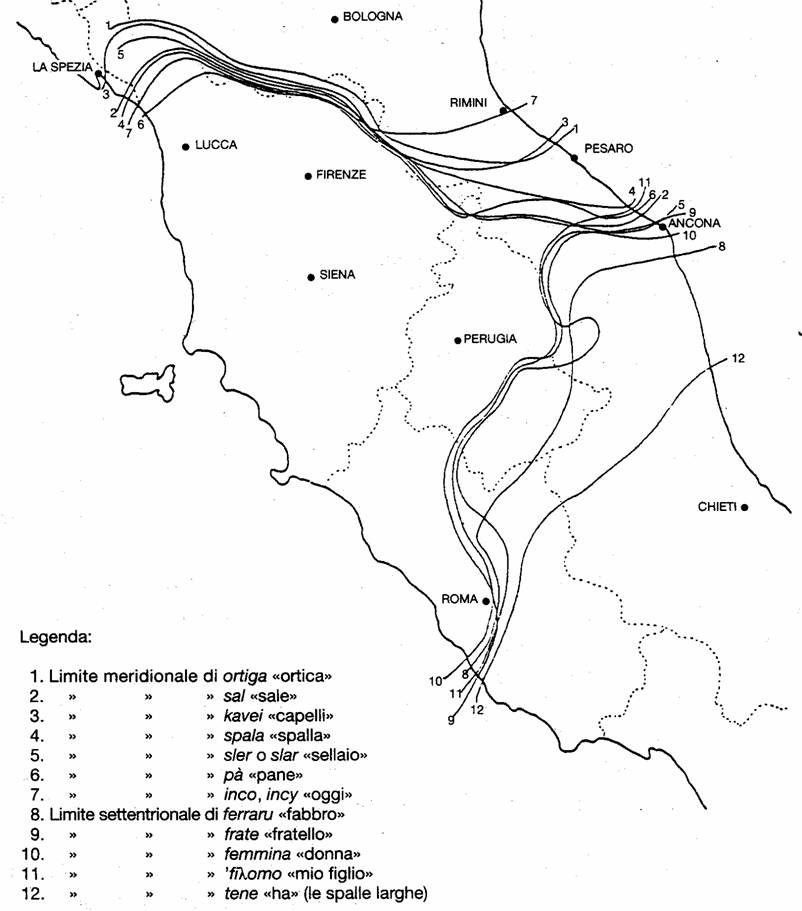
La cartina, riprodotta
per gentile concessione dell’editore, è contenuta nel volumedi
Grassi-Sobreo-Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana.
Roma-Bari, Laterza, 2003.
1.5
1.5 Il settefratese scritto
top
I testi scritti
in settefratese sono molto pochi. Spesso si tratta di componimenti
scherzosi o occasionali. Dal punto di vista della trascrizione sono
generalmente poco affidabili. In questo panorama, e senza fare
torto ad altre personalità brillanti e interessanti che
occasionalmente hanno scritto qualcosa in dialetto, a volte magari
senza pubblicarlo, come è capitato al pittore Alfonso Capocci,
occupano un posto diverso e del tutto particolare le composizioni
poetiche di Michele Buzzeo, non solo per la quantità e la regolarità
della produzione, durata tutta la vita, ma anche per la vastità
delle tematiche liriche. Questa non è la sede per rendere ragione
degli aspetti propriamente letterari e poetici della sua opera, ma
vorrei accennare a aspetti importanti dal punto di vista
linguistico.
Per quanto
riguarda il lessico, la lirica di Michele Buzzeo rappresenta un
grande deposito di memoria dialettale, con la consapevolezza che -da
letterato quale era- in qualche misura ha recepito termini della
lingua colta o dell’italiano comune, integrandoli nel dialetto. Ma
dal punto di vista della trascrizione resta esemplare per il
tentativo di rendere il settefratese in modo piano, vicino al
meridionale comune, in maniera non ostica e incomprensibile.
Purtroppo devo dire con rammmarico che, nonstante la presenza su
settefrati.net di una cospicua raccolta di poesie, la sua lezione è
stata quasi completamente dimenticata e non è stato seguito da
quelli che si sono cimentati nel dialetto scritto, che in generale,
anche se certamente con buona intenzione, tendono invece a produrre
testi veramente “giargianesi”, intessuti di apostrofi in luogo delle
e semivocali debolmente pronunciate.
A mio parere un
ritorno alla nettezza classica dei segni fonetici presenti nelle
poesie di Michele Buzzeo -con una marcatura più sistematica e
regolare dell’accento tonico e qualche riaggiustamento nell’uso di q
e c- costituirebbe un buon programma per lasciarsi alle spalle le
trascrizioni disordinate e depistanti che di solito si leggono
nella produzione locale.
Ricapitolando,
la mia proposta per la scrittura in dialetto è questa:
1)
Nell’ambito di una ricerca professionale di tipo
linguistico-dialettologico, vigono regole specifiche per tutti i
caratteri, vocali e consonanti che siano (trascrizione fonetica).
2)
Per un uso non specialistico, nel contesto di una citazione
specifica, di un elenco, di un dizionario non professionale, dove
però si deve comunque evidenziare l’esatto contenuto fonetico, è
necessario segnalare:
a.
l’accento nella sillaba tonica di ciscuna parola, che è l’epicentro
del sistema fonetico settefratese; di più, occorre che per la e
e per la o sia correttamente segnato l’accento grave (è
ò) per la pronunzia aperta e l’accento acuto (é ó
) per la pronunzia chiusa;
b.
le
e semivocaliche: dopo qualche riflessione e qualche buon
consiglio, sono arrivato alla conclusione che è preferibile e più
leggibile l’uso della notazione standard dei lavori dialettologici,
ovvero la e con la dieresi (ë).
c.
per la a e la i e u la accentate è sufficiente
un solo tipo di accento perché non hanno la variazione del suono
aperto/chiuso; generalmente le tastiere di computer offrono
l’accento grave (à, ì, ù).
Esempi: fërràrë,
cuónë, òssa, gërëcónë, frèvë, chéssa
Avvertenza:
con le tastiere senza caratteri accentati ricordo che si possono
comunque ottenere con i tasti ALT + numero corrispondente
à ALT+133
è ALT+130
é ALT+138
ë ALT+137
ì ALT+141
ò ALT+149
ó ALT+162
ù ALT+151
3)
Per un uso letterario (epigrammatico, lirico, narrativo) può essere
auspicabile che il testo non sia appesantito da segnalazioni
speciali; perciò
a.
può essere sufficiente marcare la sillaba accentata, grave o acuta
quando necessario (vedi punto 2 a); questo si può praticare
tranquillamente, non perdendo nessuna segnalzione fonetica
importante, perché la regola che le e non accentate si
pronunziano debolissime non ha eccezioni.
Esempi:
ferràre, cuóne, òssa, gerecóne, frève, chéssa
b.
nel caso di difficoltà a disporre di tastiere con le vocali
accentate, e anche ad utilizzare il codice ASCII esteso, sarebbe
preferibile attenersi alla trascrizione più “classica” possibile,
appunto secondo la lezione di Michele Buzzeo, restituendo al
dialetto semplicità e scorrevolezza, ed eliminando drasticamente
l’uso di altri segni che lo rendono ostico e incomprensibile. E’
evidente che operando in questo modo si ha lo svantaggio che bisogna
“sapere” dove cade l’accento, per distinguere le e semimute,
e bisogna anche sapere se la pronunzia di o e e è
aperta o chiusa: perciò è chiara la mia decisa preferenza per al
soluzione 3 a ; con la 3 b si paga “dazio”, ma il costo tutto
sommato sarebbe certamente più basso di quello che paghiamo leggendo
i prodotti poetici degli ultimi tempi, a volte simpatici e arguti,
ma resi complicati nella lettura, con tutte le incertezze e le
incoerenze connesse alla notazione delle e in corpo di parola e in
finale (del tipo: f’rrar, cuon, g’r’con ecc.)
Esempi:
ferrare, cuone, ossa, gerecone, freve, chessa
2. FONETICA
top
2.1 Le vocali
top
Il sistema
vocalico del dialetto di Settefrati, come di tutte le parlate
dell’Italia centro-meridionale, è governato dall’accento: questa è
la ragione principale che spiega la maggior parte delle differenze
rispetto alle parole dell’italiano comune. Potremmo dire che quello
che accade in questo ambito è forse il punto più complicato della
fonetica settefratese, e richiede una spiegazione abbastanza
tecnica.
Nella sillaba
non accentata
le vocali e, i, o, u si riducono a
semivocale ë, debolmente ma sicuramente pronunciata: questo
fenomeno è osservabile praticamente in tutte le parole dialettali.
Nella sillaba
accentata,
vero e proprio centro fonetico della parola, in concomitanza con la
riduzione descritta sopra, si producono due variazioni:
a)
dittongazione, ossia la vocale semplice accentata si trasforma
in dittongo: esempio tipico la o latina che diventa uo
(bonus/ buónë, porcus/puórchë); in settefratese la dittongazione
coinvolge anche la a accentata (che poi cambia il suono in
o e in e: questo passaggio ulteriore è spiegato
analiticamente più avanti)
b) metafonesi,
ossia cambiamento di suono, spesso per influenza della vecchia
vocale finale indebolita in ë: esempio tipico chiave/chiévë;
La a non
accentata invece è più resistente: non si degrada a e
semivocalica, e contemporaneamente nella parola non si produce il
fenomeno dittongazione + metafonesi nelle vocali o e a
della sillaba con l’accento:
quindi nel
complesso abbiamo un esito assai più vicino all’italiano comune
(buónë, ma f. bòna, cuónë
ma f. càna, uóssë
ma pl. òssa).
Questi tre
fenomeni spesso si combinano insieme e complessivamente accade che
la vocale della sillaba tonica della parola viene anzitutto
enfatizzata e “marcata” con un suono più forte e prolungato;
contemporaneamente (storicamente forse in una fase successiva) è
sottoposta anche a cambiamenti di suono (metafonesi), mentre le
vocali delle sillabe non accentate (a meno che non si tratti di a
non accentata, come abbiamo visto) si indeboliscono, fino quasi a
scomparire, trasformandosi nella semivocale ë: cosicché tutta
la parola latina sembra come ricostruirsi attorno alla sillaba
accentata, vero e proprio “epicentro” di quello che potremmo
chiamare un “terremoto fonetico”.
Una ulteriore
“enfatizzazione” della sillaba accentata è data dalla frequente
presenza di raddoppiamento nella consonante che segue la vocale o il
dittongo accentato nelle parole sdrucciole, vale a dire nelle quali
l’accento cade sulla terzultima sillaba (esempi: uóssënë, àssëna,
fràttëmë, màcchëna, marìttëmë, miéddëchë).
Anche questa uleriore marcatura è specifica di Settefrati centro e
già a Pietrafitta è assente.
Detto in altri
termini, il dittongo come esito abituale della vocale tonica in
presenza di e, i, o, u (ovvero
della loro succedanea ë semivocalica) in finale di parola è
un fenomeno ben radicato anche nell’italiano comune (buono da
bonus), anche se abbastanza estraneo al toscano; nelle parlate
centro-meridionali riguarda in modo prevalente la o
accentata; nel settefratese (in Val di Comino sembra una sua
caratteristica quasi esclusiva, ma si riscontra con un grado diverso
anche a San Donato ed è presente in varie parlate abruzzesi e
molisane) si manifesta anche in presenza di a tonica,
producendo alla fine uó, se la finale della parola è una ë
da o/u, ié se la finale della parola è una ë da e/i (cuómpë
/chiémpë, cuónë/chiénë): alla dittongazione in questo caso si
associa visibilmente la metafonesi, ovvero: nel caso del dittongo
formato a partire dalla a (che darebbe ua o
ia tipo cuànë/kiànë) la a (che
tecnicamente è una vocale velare) subisce anche un cambiamento di
suono verso la e (che è una vocale palatale), se preceduta
dalla palatale i, e verso la velare o se preceduta
dalla velare u (puónnë/piénnë,
uóssënë/iéssënë,
cuónë/kiénë).
Probabilmente questo fenomeno si è verificato in una stadio
successivo e si spiega con l’ armonizzazione dei suoni vocalici (u-o,
e i-e sono più vicine e “facili” da pronunziare di u-a
e i-a).
(1)
La metafonesi è
comunque molto attiva in vari contesti: la a che tende
sempre a diventare e dopo una i (kiévë,
magnié), l’alternanza maschile/femminile (rùscë/róscia, nfùssë/nfóssa,
ùrsë/órsa)
e del singolare/plurale
(uóvë/òva uóssë/òssa, pócë/pùcë), la coniugazione del verbo (i’
magnë/tu miégnë, i’ bévë/tu bìvë).
La massima
intensità del fenomeno si riscontra nel centro, e si attenua o si
presenta con connotati diversi man mano che ci si spinge verso le
frazioni del territorio comunale e poi nei paesi vicini.
La dittongazione
a carico della a, ma con gradazioni diverse, è attestata
abbastanza sia in area nord-campana che abruzzese-molisana. A San
Donato Val Comino
(2), ad
esempio, paese confinante a Nord, abbiamo una situazione
cuànë/kiànë, uàsënë/iàsënë, cuàmpë/kiàmpë.
Per quanto
riguarda gli esiti della e e della i accentate, la
situazione è piuttosto complessa, ma non dissimile dagli altri
dialetti dell’area: e, i, u lunghe latine
conservano generalmente il suono intatto (léna, réna, fìnë/fìna,
vìnë, vìtë, nìdë, lùcë, ùva, crùdë); per il resto c’è da notare una
consistente presenza di metafonesi che, al solito, marca la
differenza singolare/plurale (mésë/mìscë, pìrë/péra, dèntë/diéntë,
pèdë/piédë), ovvero maschile/femminile (chìnë/chiéna).
(1)
Il passaggio dalla a alla e è un fenomeno frequente in molti
dialetti italiani: è particolarmente riconoscibile nel versante
adriatico, dall’Emilia-Romagna alla Puglia, dove si presenta
intensissimo, ed è chiamato dai linguisti “palatalizzazione
adriatica”
(2)
Il dialetto di San Donato V.C. è molto documentato (Inchiesta AIS
1924, punto 701 e, recentissimo, il lavoro di Daniela Farina, Il
dialetto di San Donato in Val Comino, pubblicato nel 2001; a quest’
ultimo, che ho consultato ampiamente, anche per le numerose affinità
tra le parlate dei due paesi, rimando il lettore che volesse
approfondire con una trattazione analitica e specialistica
dell’argomento.
2.2 Le consonanti
top
Il sistema
consonantico del dialetto settefratese è complessivamente coerente
con gli esiti prevalenti nell’area centro-meridionale d’Italia, in
particolare nel Lazio meridionale, nell’area campana e in quella
abruzzese-molisana. Perciò mi limito a segnalare solo le
caratteristiche più importanti.
Si rileva nel
centro una tendenza diffusa a raddoppiare la pronunzia delle
consonanti in corpo di parola (es. màcchëna, contro màchëna della
campagna e di Pietrafitta).
Esiti principali
b:
iniziale e intervocalica si presenta come v (vócca, varìlë, vàrva,
vàva ) o come bb, con pronuncia intensa (bbiéglië, bbuónë, sàbbëtë,
sùbbëtë), talora per ipercorrettismo (bbàligia) o per influenza
dell’ italiano comune (bbàrba invece del più arcaico vàrva);
c:
generalmente davanti a i e e si palatalizza e si
pronunzia quasi sc ( es. vuócë, pócë);
d:
non presenta particolarità notevoli: la tendenza a trasformarsi in r
in posizione intervocalica, frequente nel meridione e caratteristica
del sandonatese, è quasi inesistente;
fi, fl:
l’esito abituale è sc (sciùmë, sciuórë, scënnàtë, sciónna,
rësciatà);
g:
iniziale ha un comportamento molto vario: di solito si presenta
come i (iàtta, iërànë, iënèstra) o u/v (vuóllë), ma abbiamo anche
gg (ggiòstra) in parole evidentemente entrate nell’uso più
recentemente e/o influenzate dalla forma dell’italiano comune;
ovvero perde sonorità (kaglìna) se seguita da vocale velare; in
posizione intermedia tende a mutare in v (fràvëla);
gn:
si presenta prevalentemente come n, più propriamente in, con
palatalizzazione conservata o meno da i (ainùccë, léna);
l:
iniziale quasi sempre si conserva inalterata (lìma, lénga), ma
palatalizza se seguita da i/u (gliùna, gliunëdì, glìva);
nell’intervocalica si presenta, non regolarmente, l’alteranza con r
(pìrë , carëcàra );
lc, ls:
la l si muta in v (càvëcë, fàvësë) o cade (pócë);
ld, lt:
almeno 3 esiti: l si presenta come vë (savëtà), si raddoppia con
assimilazione della d (càllë), diventa r (cuërtiéglië);
ll:
intervocalica normalmente palatalizza in gl (capìglië, cavàglië,
tuóglië);
mb:
si presenta come m o mm (mëglìccuërë, mmëttìglië) per
assimilazione;
nd:
dà nn (cannéla, mùnnë, mënnézza) per assimilazione, come in tutta
l’area meridionale fino a Roma, (è stata ipotizzata una
persistenza osco-sabellica); sporadicamente il nesso nd è
conservato (quand’arriva?);
nt:
la t si conserva , ma tende decisamente verso la d, sonorizzandosi
(quanda ggèntë!);
ng:
normalmente si presenta come gn (chiégnë per piangere, màgna
per mangia, ógna per unghia, ógnë per unge, mógnë per mungere;
pl (it. pi):
si presenta come ch (chiòvë, chianétta, chìnë, chiùmmë);
qu:
la consonante labiovelare kw è tendenzialmente stabile (quàttrë,
quarànta) talvolta si presenta con perdita dell’elemento labiale
(ca da quia, cocùnë da qualcuno, cìnkë da quinque, càma da squama);
s:
in posizione iniziale generalmente si conserva , o passa a “z”,
come in italiano comune; nei gruppi consonantici st e sk, tende a
schiacciarsi, dando come esito un un suono palatalizzato tipo “sc”;
t
: dopo nasale si
sonorizza e tende a d (vedi sopra nt);
v:
iniziale solitamente si conserva (vècchia, vèspa, vèstë vìtë, ma
iólëpë, che prob. è passato da golpe, e non è direttamente da
vulpis); e così pure intervocalica (nèvë, nòvë, lavà), con qualche
caso di caduta (iènca da iuvenca), o in espressioni come
“m’uóglië” da “më vuóglië”.i
caduta (iènca da iuvenca);
3. MORFOLOGIA
top
3.1 I nomi
top
Il genere dei
nomi è in gran parte identico all’italiano comune; casi sporadici di
cambiamento di genere (es. la fànga) saranno via via segnalati nel
dizionario. E’ invece significativa la presenza del neutro per una
serie di parole che designano cose non quantificabili, e sono
riconoscibili per l’uso dell’articolo lë invece del glië
proprio del maschile. Questo neutro particolare, esistente in molte
parti dell’Italia meridionale, non ha rapporto con il neutro latino,
ed è chiamato “neutro di materia” o “neo-neutro” o “neutro romanzo”
(cfr. Farina, 106) (es. càcë, làttë, pànë, sàlë, vìnë, uóglië,
acìtë, mèlë, sànghë). E’ invece direttamente collegato al neutro
latino il plurale in –ëra (da –ora) (es. càmpëra, téttëra, chiòvëra,
bócchëra).
Come già
ricordato a proposito della fonetica delle vocali, nelle
articolazioni maschile/femminile degli aggettivi e singolare/plurale
degli aggettivi e dei nomi è fortemente presente il fenomeno della
metafonesi.
3.2 I pronomi
top
Personali
soggetto: i’,
tu, ìssë/éssa, nu’, vu’, ìssë/éssë;
complemento: më,
të, glië/la, në, vë, glië/lë.
Possessivi
Glië mié, glië
tié, glië sié, glië nuóstrë, glië vuóstrë, glië sié.
Gli aggettivi
possessivi mio (mié) e tuo (tié) sono enclitici nelle parole che
indicano parentela e simili *(fìgliëmë, fràttëmë, sòrda,
pàrtë, màmmëta, nònnëtë, càsta, ecc.), ma è presente, a seconda del
contesto, anche il tipo la casa méa, glië fìglië mié ecc.
Dimostrativi
Cosa: quéstë,
quéssë (equiv. a codesta cosa), quéllë;
Persona:
quìstë/chésta, quissë/chéssa, quìglië/chélla, al plurale
chìstë/chéstë, chìssë/chéssë, chìglië/chéllë.
Gli aggettivi
dimostrativi sono uguali o con aferesi iniziale: stë/sta, ssë/ssa,
quìglië/chélla, plurale stë, ssë, chìglië/chéllë.
Da notare la
presenza di tutte e tre le articolazioni proprie dell’italiano colto
e del toscano parlato (questo, codesto, quello): nel passaggio del
parlante dal dialetto alla lingua comune codesto si perde;
analogamente accade negli avverbi di luogo.
Indefiniti
Coccósa,
cocùnë/cocùna.
* Per questa tipologia tipicamente meridionale, vedi la cartina a
pag. 12., dove è mostrata la cosiddetta “isoglossa di figliomo”.
3.3 I verbi
top
Qui è presentata
sinteticamente la coniugazione degli ausiliari, dei servili e delle
coniugazioni standard; nel dizionario si darà conto di altri casi
particolari.
Essere (èssë)
I’so’, tu siè,
ìssë/éssa è, nu’ sémë, vu’ sétë, ìssë/éssë suó.
Part. passato
stàtë; cong. cond. fóssë; imperfetto: éva, ìvë, éva, avàmë, avàtë,
évenë; passato remoto: fùsë , fuóstë, fó, ….fuórnë.
Stare (stà)
I’ stònghë, tu
stié, ìssë/éssa stà, nu’ stémë, vu’ stétë, ìssë/éssë stiévë.
Part. passato
stàtë; cong. cond. stèra, stéssë; ger. stènnë; imperfetto: stèva,
stìvë, stéva, stavàmë, stavàtë, stévënë; pass. rem.: stìvë,
stiéstë, stèttë, stèmmë, stèstë, stiérnë.
Tenere (tené)
I’ tiénghë, tu
tiè, ìssë/éssa tè, nu’ tënémë, vu’ tënétë, ìssë/éssë tiévë.
Part. passato
tënùtë; cong. cond. tënèra, tënéssë; ger. tënènnë; imperfetto:
tënéva, tenìvë, tënéva, tënavàmë, tënavàtë, tënévënë ; pass
rem. : tënìvë, tëniéstë, tëné (ténnë ?), tënèmmë, tënèstë, tëniérnë.
Funge normalmente
da verbo ausiliare al posto di « avere » ; nell’area meridionale si
alterna con « aggia », che si riscontra nella stessa Valle di
Comino.
E’ da rilevare
che in linea di massima il verbo ausiliare per la costruzione del
passato prossimo è sempre “essere”; “tenere” è utilizzato per la
formazione di molte locuzioni tipiche (më tè fàmë, më tè sétë, më tè
suónnë) e per le perifrasi del futuro, anche per indicare l’aspetto
durativo o di necessità (tiénga ì da “tienghe a ì”, tiérna i’ da “tëniénë
a i’ ”, tèra fa da “tè da fà”, téta dicë da “tënéte a dìcë”). In
questo caso all’imperfetto si usa però l’ausiliare avéva ecc. e la
passato remoto “uósa, uósta, òsa, òmma, òsta, uórna”, (forse
contrazione di habui, habuisti ecc.?)
Potere (pëté):
i’ pòzzë, tu può, ìssë/éssa pò, nu’ pëtémë, vu’ pëtétë, ìssë/éssë
puóvë.
Part. passato
pëtùte; cong. cond. pòzza, pëtèra, pëtéssë; imperfetto:
pëtéva, pëtìvë, pëtéva, pëtavàmë, pëtavàtë, pëtévënë; pass. rem.:
pëtìvë, pëtiéstë, pëté (pòsa), pëtèmmë, pëtèstë, pëtiérnë
(puórna).
Volere (vëlé):
i’ vuóglië, tu vuó, ìssë/éssa vò, nu’ vëlémë, vu’ vëlétë,ìssë/éssë
vuóvë.
Part. passato
vëlùtë; cong. cond. vëlèra, vëléssë; ger. vëlènnë; imperfetto:
vëléva, vëlìvë, vëléva, vëlavàmë, vëlavàtë, vëlévënë; pass. rem.:
vëlìvë, vëliéstë, vëlè, vëlèmmë, vëlèstë, vëliérnë.
Abituale la
caduta della v iniziale nelle espressioni m’ uóglië (da me
vuóglië) e simili.
Dare (dà):
i dònghë, tu diè, ìssë/éssa dà, nu’ démë, vu’ détë, ìssë/éssë diévë.
Part. passato
dàtë; cong. cond. dèra, déssë; ger. dènnë; imperfetto: déva, dìvë,
déva, davàmë, davàtë, dévënë.
Fare (fà):
i’ faccë,
tu fié, ìssë/éssa
fà, nu’ facémë,
vu’ facétë,
ìssë/éssë
fiévë.
Part. passato
fàttë; cong. cond. facèra, facéssë; ger. facènnë; imperfetto:
facéva, facìvë, facéva, faciavàmë, faciavàtë, facévënë; pass. rem.:
facìvë, faciéstë, facé (fécë), facèmmë, facèstë, faciérnë.
Andare (i’)
: i’
vàglië, tu vié, ìssë/éssa và, nu’ iémë, vu’ iétë, ìssë/éssë viévë
(con alternanza dei temi vad- e ir-, mentre l’italiano comune
alterna vad- e and-).
Part. passato:
ìtë; cong. cond. ièra, ìssë; ger. iènnë; imperfetto : ìva, ìvë, ìva,
iavàmë, iavàtë, ìvënë; pass. rem.: ìvë, iéstë, ì, ièmmë, ièstë,
iérnë.
Venire (vënì/mënì:
l’aternanza ven/men si presenta in tutti i tempi, con variazioni a
volte legate alla persona): i’ viénghë, tu viè, ìssë/éssa
vè, nu’ vënìmë, vu’ vënìtë, ìsse/éssë viévë.
Part. passato
vënùtë/mënùtë; cong. cond. vënèra/mënèra vënìssë/mënìssë; ger.
vënènnë; imperfetto: vënìva, vénivë, vënìva, vënavàmë, vënavàtë,
vënìvënë; pass. rem.: venìvë, veniéstë, vénnë (vënì?), vënèmmë,
venèstë, vëniérnë.
Verbi in -are
(-à/-ié):
Mangiare
(magnié): i’ màgnë, tu miégnë, ìssë/éssa màgna, nu’ magniémë, vu’
magniétë, ìsse/éssë màgnënë.
Part. passato
magniétë; cong. cond. magniéssë, magnèra; ger. magnènnë; imperfetto
magniéva, magnièvë, magniéva, magnavàmë, magnavàtë, magniévënë;
pass. rem.:magniévë, magniéstë, magniè, magnièmmë, magnièstë,
magniérnë.
(notare
l’alternanza metafonetica à/ié)
Pisciare
(pëscié) : i’ pìscë, tu pìscë, ìssë/éssa pìscia, nu’ pësciémë, vu’
pësciétë, ìssë/éssë pìscënë.
Part. passato
pësciétë; cong. cond. pësciéssë, pëscièra; ger. pëscènnë; imperfetto
pësciéva, pësciévë, pësciéva, pësciavàmë, pësciavàtë, pësciévënë;
pass. rem. pësciévë, pësciéstë, pëscié, pëscièmmë, pëscièstë,
pësciérnë.
L’alternanza
à/ié è correlata dalla presenza della vocale palatale i. In
assenza (es. abbëttà, abbëlà, acchiappà, aspëttà, lavà, rancëcà) si
ha: aspèttë, aspiéttë, aspètta, aspëttàme, aspëttàte, aspéttënë; pp.
aspettàtë ecc.) con conservazione della a del tema. (lavàmë contro
magniémë)
Verbi in ere
(-eve)
Bere
(vévë/bbévë): i’ bévë, tu bìvë, ìssë/éssa bévë, nu’ bëvémë, vu’
bëvétë, ìssë/éssë bìvënë.
Part. passato
vìvëtë/bìvëtë, più rec. bëvùtë; cong. cond. bëvéssë; ger. bëvènnë;
imperfetto bëvéva, bëvìvë, bëvéva, bëvavàme, bëvavàtë,
bëvévënë; pass. rem. bëvìvë, bëviéstë, bëvé, bëvèmmë, bëvèstë,
bëviérnë.
Per questo verbo
si registra nei parlanti un’oscillazione fra la regolare v (cfr.
fonetica, consonante b) e la tendenza a utilizzare la bb, come
accade in bbàrba nei confronti del più arcaico ma praticamente
desueto vàrva.
Per quanto
riguarda il part. pass. la forma appropriata vìvëtë tende a essere
soppiantata da
bëvùtë,
analogamente a quanto si verifica con chiuóvëtë/chiëvùtë,
presumibilmente per influenza dell’italiano comune.
Verbi in ire
(-ì)
Partire (partì):
i’ pàrtë, tu piértë, ìssë/éssa pàrtë, nu’ partìmë, vu’ partìtë,
ìssë/éssë piértënë (alternanza metafonetica à/ié).
Part. passato
partùtë/rec. partìtë; cong. cond. partìssë, partèra ;
ger. partènnë; imperfetto partìva, partìvë, partìva, partavàmë,
partavàtë, partivënë; pass. rem. partìvë, partiéstë, partì,
partèmmë, partèstë, partiérnë.
Per quanto
riguarda partùtë/partìtë vedi quanto detto sopra per chiuóvëtë e
vìvëtë.
3.4
Articoli, congiunzioni, avverbi
top
Gli articoli
determinativi sono glië/la sing., glië/lë plur., lë per i neutri di
materia tipo lë pànë (vedi quanto detto per il genere dei nomi);
quelli indeterminativi në/na.
Preposizioni
congiunzioni e avverbi non presentano particolari casistiche
morfologiche. Rimandando al dizionario per la trattazione caso per
caso delle particolarità fonetiche e lessicali, segnalo alcuni casi
più caratteristici, come ad esempio la congiunzione ca da quia, con
caduta della labiale (vedi in fonetica-consonanti quanto detto per
qu/kw).
Fra gli avverbi
di tempo è opportuno notare maddëmànë e masséra (stamane, stasera),
uónnë iànnë iënòttë (quest’anno, l’anno scorso, la scorsa notte),
iëtèrza (l’altro ieri, da die tertia) pëscrié (dopodomani, da
postcras, mentre domani è presente come addëmànë), pëscrìglië
(il giorno dopo dopodomani), céttë (presto), ndànnë (un tempo).
Per gli avverbi
di luogo, analogamente ai pronomi dimostrativi, è da segnalare la
presenza delle tre articolazioni proprie dell’italiano colto e del
toscano parlato (iécchë, iéssë, lòchë per qui costì, lì): anche in
questo caso nel passaggio all’italiano comune si perde la nozione
del “vicino a chi ascolta”.
4. Riferimenti
top
In questo
contesto non ho ritenuto opportuno indicare una bibliografia vera e
propria. Segnalo alcuni testi di riferimento, che ho utilizzato per
il lavoro, e che formano un possibile percorso per un primo
approfondimento dell’argomento.
- I dialetti
italiani: storia struttura uso, a cura di Manlio Cortellazzo et al.
Torino, Utet, 2002.
-
Grassi-Sobrero-Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana.
Roma-Bari, Laterza, 2003.
- Farina, Il
dialetto di San Donato in Val Comino. Formia, 2001.
- Merlo,
Fonologia del dialetto di Sora. Pisa, Mariotti, 1920.
-
Battisti-Anselmi, Dizionario etimologico italiano. Firenze, Barbera,
1975.
-
Cortellazzo-Marcato, Dizionario etimologico dei dialetti italiani.
Torino, Utet, 2005.